“Siamo tutti ruscelli dello stesso fiume”. Così si apre il documentario del regista cileno Patricio Guzmàn. Un preambolo poetico e visionario per un film che, attraverso la considerazione di come l’intero universo sia permeato dell’elemento acquatico, arriva a riflettere sul tema della memoria che lega il Cile – terra natia del regista – a un destino di sanguinosa violenza.
Un viaggio nella storia di un Paese dalla memoria scomoda che si dibatte nello sforzo di dimenticare ciò che non può essere dimenticato. Un film di cui parlare perché ci fa crescere e ci porta nuova consapevolezza.
L’ACQUA E’ IL TRAMITE TRA NOI E LE STELLE
I nostri corpi, i sassi così come le stelle sono composti d’acqua e qual è la prerogativa dell’acqua? Quella di adattarsi, di prendere la forma del corpo che incontra, ma non solo: l’acqua ha memoria e nel suo scorrere, in un continuo circolo vitale che attraversa i tempi e le epoche, prima o poi riporta a galla quel che ha inghiottito.
L’autore attraverso la descrizione della tragica fine del popolo Selknams – originario della Patagonia, nel sud del Cile – porta l’attenzione sulla violenta brutalità con cui si è imposta la moderna civiltà occidentale.
Una violenza che ha intriso di sangue la terra cilena per riproporsi, decenni dopo, attraverso l’eccidio perpetrato da Pinochet sulla sua stessa gente. La memoria dell’acqua nasce allora prima di tutto da una necessità, dal bisogno intimo e personale dell’autore di portare a testimonianza la storia di un popolo intero.
IL BOTTONE DI MADREPERLA
Un popolo, quello Cileno, che ritrova le sue origini primordiali in un bottone di madreperla – che dà il titolo al documentario nella sua versione originale – restituito dall’acqua dopo decenni. Un bottone incrostato fra la ruggine di una rotaia in fondo al mare, una di quelle rotaie che al tempo della dittatura di Pinochet servivano a legare i corpi degli sventurati che poi sparivano inghiottiti dall’Oceano.
Un Oceano, quello che lambisce il Cile, che i nativi del sud avevano imparato a domare. Un mare con cui loro erano in grado di vivere in simbiosi, sfidandone i pericoli e le asperità sulle loro piccole canoe. Nativi dagli occhi dolci e disperati cui la civiltà europea ha tolto l’anima, per un bottone.
La genialità nella scrittura di questo capolavoro, che non a caso ha vinto il premio a Berlino per la miglior sceneggiatura, è stata quella di aver saputo creare un nesso originale tra i concetti cardine di acqua, violenza e memoria.
Un viaggio nel tempo e nello spazio come quello intrapreso da Jimmy Button, indigeno della terra del fuoco che il capitano FitzRoy nell’800 si preoccupò di educare e “civilizzare” portandolo in Inghilterra. Pare che Jimmy accettò di seguirlo in cambio di un bottone. Quando anni dopo venne riportato nella terra d’origine aveva ormai perso la sua identità.
Con un viaggio oltreoceano – che per Jimmy significò il passaggio dal paleolitico alla Rivoluzione industriale – si aprirono le rotte per i coloni che in pochi anni portarono alla decimazione dei popoli del sud e avviarono quella spirale di violenza che sembra aver contaminato il suolo cileno. Una violenza indicibile, di cui è necessario mantenere viva la memoria, come fa l’acqua di cui siamo composti.








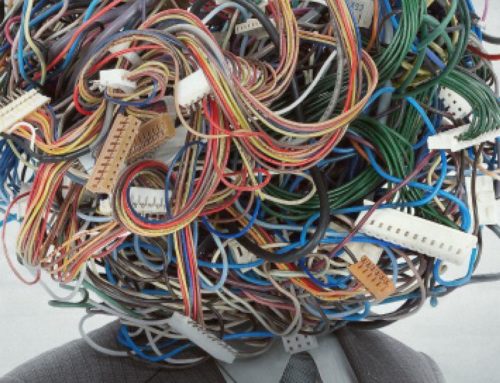

Non ho visto il documentario ma la tua recensione mi ha incuriosita parecchio. Da amante dell’America Latina, appassionata di letteratura, cinema e arte, non poteva che essere così per cui dovrò assolutamente rimediare quanto prima…
Non so se è una cavolata quella che sto per dire ma io considero l’America Latina una “figlia adottiva” della violenza… dal massacro perpetrato dai conquistadores a danno delle popolazioni native alla serie di dittature autrici di genocidi dalle proporzioni epiche! A volte, quando viaggio per quella terra che amo, mi chiedo come fa la gente a essere sempre così ben predisposta verso di me, verso di noi…
Va beh, non è questo il luogo atto a elucubrazioni filosofico-esistenziali!
Buona giornata
Ciao Diana, sempre un piacere averti qui… fai fai, elucubra pure! :-D invece io scrivo proprio perché mi piace riflettere su certe cose e se ne viene fuori uno scambio in tal senso sono sempre felice. Non dici una cavolata quando consideri l’America Latina figlia della violenza, è il motivo che in realtà me ne ha sempre tenuta lontana, preferendo l’Asia. Ho viaggiato solo in un piccolo pezzo di Argentina e Uruguay e poi a Cuba, quindi la mia reale conoscenza del territorio è più che altro demandata alle fonti… Quando eravamo in Argentina mi sono trovata in più di un’occasione a dover specificare che io e la mia amica (che parla un ottimo spagnolo), non eravamo Spagnole. In realtà la buona disposizione nei nostri confronti arrivava solo dopo, quando scoprivano che eravamo Italiane. Penso che, nonostante i mille difetti, noi Italiani sappiamo farci amare nel mondo. Non siamo un popolo conquistatore e anzi, storicamente abbiamo più subito che altro, soprattutto dagli spagnoli. Questo ci accomuna molto ai sud americani. In particolare però è anche vero che questa ferita, questa piaga della violenza intrinseca nella cultura di certe popolazioni è quanto mai forte proprio in Cile, un paese che purtroppo non conosco. Ti consiglio, se ti piace, di approfondire tutto il cinema di Guzman e, perché no, di Larrain. Un abbraccio
Grazie mille! Lo farò sicuramente… la mia passione per l’America Latina, al di là dei paesaggi strepitosi e tantissimi altri pregi che le riconosco conoscendola discretamente bene (anche se non è mai abbastanza), è a 360°. L’impulso a partire per il mio primo viaggio è seguito alla lettura di un libro che parlava dei desaparecidos argentini e quel viaggio ha svoltato la mia vita. Rientrata in Italia ho interrotto i miei studi in giurisprudenza e alla fine, con un po’ di anni di ritardo, mi sono laureata in Letterature Ispano-Americane. Amo questa terra e amo questi popoli che nonostante tutto non si arrendono mai e affrontano la vita con il sorriso sulle labbra, sempre e comunque!
Un abbraccio e a presto